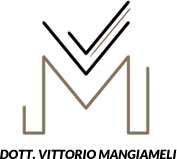Per mobbing si intende non una patologia, ma una forma di terrore psicologico messa in atto nell’ambiente di lavoro mediante una serie di comportamenti aggressivi e vessatori deliberatamente voluti, ripetuti nel tempo, da parte del datore di lavoro, superiori o colleghi nei confronti di una vittima designata, con gravi conseguenze a livello psicofisico. Il soggetto può essere sistematicamente calunniato, emarginato, deriso e sottoposto a compiti dequalificanti attraverso varie modalità che hanno come finalità ultima quella di portarlo alle dimissioni volontarie o a un licenziamento.
Caratterizzandosi come fenomeno complesso e multifattoriale il mobbing prevede la compresenza di diversi attori che possono interagire tra loro in maniera diversa ma sempre peculiare. La vittima del mobbing è il cd. mobbizzato. Non esiste un profilo o una categoria di persone che possono essere maggiormente predisposte a diventarlo, ma possono essere individuate alcune situazioni tipo o configurazioni contestuali che sono state riscontrate con particolare frequenza. Si pensi a esempio a una donna in un ufficio di soli uomini (o viceversa), a un giovane inserito in un team già affiatato di esperti, a una persona ben qualificata a livello di titoli ma con scarsa esperienza professionale assunta direttamente come capo ufficio o a un unico dipendente con spiccate competenze, di molto superiori rispetto agli altri colleghi. Ricerche in merito alla condotta post mobbing della vittima hanno mostrato che esistono due particolari pattern comportamentali: il primo prevede una diminuzione dell’attività comunicativa verbale e non verbale, una riduzione dei rapporti interpersonali e del volume di lavoro eseguito; il secondo invece è caratterizzato da un incremento dell’attività gestuale e verbale e da un aumento del grado di attività e coinvolgimento lavorativo. Nessuno dei due modelli comportamentali ha mostrato apportare risultati significativi; questo perché la condotta mobbizzante, l’isolamento della vittima e la finalità distruttiva sono fondamentalmente decise a priori, indipendentemente dal comportamento del mobbizzato, che anzi spesso è preso a pretesto dell’azione vessatoria.
L’autore o il pianificatore dell’azione mobbizzante è invece il cd. mobber. Più che un profilo individuale è possibile estrapolare un profilo motivazionale che guida il comportamento di questa figura. Paura di essere superato da qualcuno più qualificato e preparato, timore di perdere la posizione lavorativa guadagnata nel lungo periodo a beneficio di terzi, volontà di abbattere qualsiasi ostacolo (o presunto tale) si ponga davanti, antipatia o intolleranza anche immotivata, difficoltà di adattamento a un contesto mutato rispetto a quello usuale, sono solo alcuni dei pretesti alla base dell’azione vessatoria. Il mobber può agire da solo o cercare supporto e alleati e può mettere in atto una strategia passiva, attiva o mista. Le strategie passive utilizzano modalità meno dirette e si incentrano generalmente sull’ignorare la controparte, affidare un carico di lavoro esagerato e mettere sotto pressione con scadenze. Le strategie attive invece puntano sulla critica e la presa in giro sistematica nei confronti del mobbizzato ma anche sul mettere in moto un circolo vizioso di false voci sul suo conto.
Nel fenomeno del mobbing assumono rilievo anche i cd. spettatori, cioè tutte quelle persone che non sono coinvolte direttamente, ma lo sono in maniera diversa o riflessa. A esempio un collega che assiste sistematicamente all’azione vessatoria, non la denuncia, non difende o non cerca di interrompere il circolo vizioso può configurarsi anche come un side-mobber che alimenta il fenomeno attraverso l’indifferenza e l’indisponibilità a intervenire, creando addirittura un substrato fertile al suo sviluppo. Lo spettatore, inoltre, potrebbe avere la possibilità e gli strumenti per mettere un punto all’azione vessatoria, in caso di riconoscimento della stessa e posizionamento in organigramma superiore rispetto al mobber.
Rispetto ai soggetti coinvolti e alla loro posizione gerarchica in azienda o ufficio è possibile individuare diverse macrocategorie di mobbing:
- mobbing verticale: la condotta persecutoria coinvolge soggetti posizionati diversamente lungo la scala gerarchica. Può essere di tipo discendente quando è un superiore o il datore di lavoro a esercitare la condotta vessatoria nei confronti di un sottoposto. In questo caso si può parlare anche di bossing. Diversamente si fa riferimento al tipo ascendente quando è il subordinato a attaccare un soggetto a lui sovraordinato;
- mobbing orizzontale: la condotta mobbizzante è esercitata da uno o più colleghi posti allo stesso livello della mobbizzato;
- mobbing misto: è esercitato sia da colleghi pari grado della vittima sia da uno o più superiori, i quali solidarizzano contro il mobbizzato per motivi simili o eterogenei.
L’impatto del mobbing sulla sfera psichica individuale può cagionare una menomazione dell’integrità psicofisica, con emersione psicopatologica (danno biologico psichico) o di alterazioni nel modo di vivere ed esperire le relazioni lavorative, sociali, e familiari; queste ultime possono intaccare la piena espressione della personalità nel mondo esterno (danno esistenziale) e generare contestualmente uno stato di sofferenza psichica causata dal trauma o dall’atto illecito (danno morale).
In tale contesto, dal punto di vista giuridico, per poter definire delle azioni o una serie di atti come mobbizzanti devono essere presenti tre condizioni fondamentali:
- elemento soggettivo: è necessaria l’intenzionalità dell’atto, deve essere quindi presente la volontà da parte del mobber di colpire qualcuno per arrecargli danno e/o per trarne beneficio in maniera diretta o indiretta;
- elemento temporale: le azioni vessatorie devono essere ripetute nel tempo, portate avanti di settimana in settimana in maniera sistematica e cumulativamente per un periodo costituente più mesi;
- elemento dannoso: le azioni devono arrecare danno al soggetto, secondo una logica di causalità, dal punto di vista psicofisico, familiare, lavorativo, economico, sociale e relazionale.
Nello specifico l’art. 2087 c.c. recita che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La norma pone quindi a carico dell’imprenditore e del datore di lavoro obblighi di garanzia e protezione ai fini individuali su base contrattuale, e per questo è egli stesso che ex art. 1218 c.c. ha l’onere di provare che l’inadempimento della prestazione è dipesa da causa a lui non imputabile. Al tempo stesso il lavoratore deve invece dimostrare che sia sopravvenuto un danno da lesione dell’integrità psicofisica, evidenziando il nesso di causalità tra la condotta subita e il danno ricevuto, sia esso di natura psichica, esistenziale o morale.